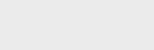LE ARTI A SIENA NEL PRIMO RINASCIMENTO
DA JACOPO DELLA QUERCIA A DONATELLO
In mostra a Siena 26 marzo - 10 luglio 2010
A Siena la mostra sul Rinascimento
Le arti a Siena nel primo Rinascimento: 300 opere d'arte, prestiti provenienti da 135 musei di tutto il mondo,
25 restauri effettuati, una ventina di polittici ricostruiti, 6 anni di preparazione.
E' questa la fantastica iniziativa sul rinascimento senese, che consiste nell'esposizione
di opere d'arte realizzate a Siena tra il 1400 ed il 1460, ed anche in una serie di percorsi alla scoperta dei tesori della città,
dal complesso museale del Santa Maria della Scala,
Opera del Duomo,
alla Pinacoteca Nazionale.
Si tratta di sculture e pitture, oreficerie ed argenterie, tessuti ed arredi, miniature
e manoscritti, molti delle quali ritornano a Siena per la prima volta. Un'occasione unica per vedere ricostruiti i polittici che nel corso dei secoli sono stati
smembrati e le cui parti sono dispersi tra vari musei europei, come il Polittico dell'Arte della Lana (1423-26)
o il Polittico dell'Altare Pecci (1426). Proprio per questo coinvolgimento europeo, l'evento è stato presentato
a Parigi ed a Londra, presso i due più prestigiosi Istituti Culturali Italiani all'estero.
In questo periodo, infatti, il Gotico stava esaurendo lentamente la sua spinta e lasciava spazio ai temi che annunciavano il Rinascimento:
fu un periodo di transizione, e proprio per questo ricco di spunti.
Il percorso espositivo
Il percorso espositivo è articolato in otto sezioni, che offrono un panorama completo del primo Rinascimento senese.
La prima sezione introduce il tema della continuità artistica tra il Quattrocento e
la grande pittura del Trecento di Simone Martini (tra le opere in mostra la celebre Annunciazione del 1333) e dei fratelli Lorenzetti, mostrando come alcuni dipinti di
questi maestri abbiano rappresentato una fonte di ispirazione per i pittori senesi del XV secolo.
La mostra sul Rinascimento a Siena prosegue con un percorso cronologico. Si inizia con Jacopo della Quercia
(Siena, 1371 ca. - 1438), protagonista assoluto di questo passaggio, il maestro del gotico internazionale,
il più grande artista della città: la sua arte, al tempo stesso elegante e possente, affascinerà anche
Michelangelo. La carriera di Jacopo è ripercorsa fin dagli inizi: dalla monumentale
'Madonna della melagrana' destinata alla Cattedrale di Ferrara (1403-1408), per passare ad alcuni dei marmi scolpiti
per la Fonte Gaia
a Siena (1414-1419), fino alle sculture in legno policromo,
come l'Annunciazione della Collegiata di San Gimignano (1421-1426) e la Madonna col Bambino del Louvre.
Un'attenzione particolare è dedicato al cantiere del Fonte battesimale, che
vide Jacopo della Quercia misurarsi con due maestri 'forestieri' che lavorarono in città nei primi decenni del '400
e giocarono un ruolo fondamentale nell'evoluzione dell'arte senese verso il Rinascimento: i fiorentini Donatello
e Ghiberti. Alla Fonte apparteneva il bellissimo Spiritello tamburino realizzato da Donatello nel 1429 ed oggi conservato
al Bode Museum di Berlino, che torna a Siena per la prima volta.
Accanto troviamo le opere dei più importanti pittori e scultori senesi di quel periodo,
come Taddeo di Bartolo, Gregorio di Cecco, Francesco di Valdambrino, Domenico di Niccolò, che ancora risentivano
dei modelli precedenti messi a punto dai fratelli Lorenzetti e da Simone Martini.
La terza sezione ha come protagonista Giovanni di Paolo (del quale si è ricostruito,
per quanto possibile, il giovanile polittico destinato nel 1426 all'altare Malavolti della chiesa di San Domenico)
e sopratutto Stefano di Giovanni, detto il Sassetta, raffinato maestro che seppe dare vita a un nuovo capitolo
della pittura senese del Quattrocento (di questo artista si sono raccolti per la prima volta tutti i frammenti
della pala dipinta nel 1423-1424 per l'Arte della Lana).
Assieme al Sassetta troviamo le opere dei suoi migliori discepoli, come Pietro di Giovanni
d'Ambrogio, il Maestro dell'Osservanza (forse da identificare con il giovane Sano di Pietro) e lo stesso Sano di Pietro,
del quale è in mostra il polittico detto "dei Gesuati" (1444), restaurato per l'occasione.
In questa porzione della mostra trova spazio anche Domenico di Bartolo, un senese atipico
che "seppe essere più fiorentino degli stessi fiorentini", il primo in città a produrre opere schiettamente rinascimentali:
la sua Madonna dell'umiltà (1433) mette ben in evidenza i rapporti con la Firenze di Filippo Lippi e Luca della Robbia;
di questo artista è anche esposta l' 'Assunta', della Fondazione Conservatori Riuniti, restaurata per l'occasione.
Con la quarta sezione termina il percorso cronologico, arrivando fino agli anni dell'ultimo
soggiorno senese di Donatello (1457-1461), con il suo ruolo ispiratore dei nuovi esponenti dell'arte senese
come Lorenzo di Pietro detto il Vecchietta, Matteo di Giovanni e Antonio Federighi.
Sono messi a confronto, a testimonianza di questa straordinaria convergenza di artisti, tre opere: il bronzeo 'San Giovanni Battista'
lasciato da Donatello alla Cattedrale, i 'Santi Pietro e Vittore' scolpiti dal Vecchietta e dal Federighi per la Loggia
della Mercanzia e infine la luminosa pala di Spedaletto, dipinta dal Vecchietta per una grancia vicino a Pienza.
Nella quinta sezione sono esposti rari esempi di oggetti della devozione:
trittichini, altaroli, dipinti per devozione privata, figure lignee del Bambin Gesù e busti reliquiario.
A chiusura del percorso troviamo le tre sezioni dedicate ai codici miniati,
all'oreficeria ed a preziosi manufatti tessili quattrocenteschi.
Il percorso verso l'uscita riserva altre piacevoli sorprese, in quanto si attraversano le
suggestive sale dell'antico ospedale, assiduamente frequentato da
Santa Caterina da Siena,
ed oggi diventato uno dei più grandi complessi museali italiani.
Prima si transita attraverso la sagrestia vecchia dell'antico ospedale, affrescato dal Vecchietta tra il 1446 e il 1449.
Quindi si raggiunge la sala del Pellegrino, istoriato tra il 1440 e il 1444 dal Vecchietta, Domenico di Bartolo
e Priamo della Quercia: da non perdere gli Episodi della storia e della vita dell'ospedale, che rappresentano
il maggiore ciclo di affreschi della Siena quattrocentesca.
>La visita alla città del Quattrocento
La mostra non si limita al percorso museale: una serie di articolate appendici prolungano la mostra nell'area del
Duomo, a pochi passi dal museo.
Infatti il biglietto della mostra, che ha 48 ore di validità, dà modo di accedere alla
Cattedrale, alla Cripta, al Battistero e al Museo Diocesano dell'Opera del Duomo, permettendo così una conoscenza
approfondita della città, la comprensione del profondo legame fra le opere d'arte e la cultura che le ha prodotte,
e la valorizzazione delle opere d'arte 'minori' custodite in questi luoghi.
Dietro presentazione del biglietto della mostra è inoltre possibile accedere alla Pinacoteca Nazionale di Siena ad ingresso ridotto.
La mostra rappresenta quindi un'opportunità di studio e di riflessione per chiunque sia
incuriosito da un momento storico in cui Siena era una delle dodici più grandi e più ricche città europee.
Inoltre la mostra, fino a maggio, si svolge in concomitanza delle iniziative della
Città del Sì,
che prevedono la disponibilità gratuita di palmari con la funzione di guida multimediale,
distribuiti presso il Complesso Museale di Santa Maria della Scala.
Vediamo nel dettaglio. L'ingresso nel Duomo permette di conoscere il meraviglioso tempio a
cui furono destinate diverse testimonianze artistiche ammirate nel percorso espositivo.
a pochi passi dal Complesso monumentale si entra nel Duomo, luogo al quale
erano destinati la maggior parte dei capolavori esposti
Nella cripta, decorata con fantastiche pitture murali duecentesche, è allestita
per l'occasione uno spazio per scoprire il mondo dell'oreficeria senese del Quattrocento:
attorno alla Lupa di Giovanni di Turino, infatti, troviamo calici, croci e reliquiari d'oro e d'argento.
Infine si raggiunge il Battistero dove,
sotto della volta affrescata dal Vecchietta con un ciclo di Articoli del Credo (1450-1453),
troviamo il grandioso Fonte battesimale, monumento per eccellenza della scultura toscana del primo Quattrocento.
Nel vicino Museo dell'Opera della Metropolitana, che conserva stupende opere d'arte
come la Maestà di Duccio da Buoninsegna, è invece allestita una sezione dedicata alla sopravvivenza
del Gotico nella Siena dei primi decenni del Quattrocento (protagonisti Gregorio
di Cecco, Domenico di Niccolò 'dei Cori' e altri). Dal Museo dell'Opera, inoltre, si accede al Facciatone,
dal quale si gode un panorama mozzafiato sulla città.
A Siena una mostra di importanza europea
La mostra sul Rinascimento senese ha una valenza europea, tanto che è stata presentata a Parigi, Londra e Roma.
Ha richiesto sei anni di preparazione, un finanziamento di tre milioni di euro e la ricerca di opere disseminate
in 100 musei nazionali e 35 internazionali (uno è perfino in Australia).
Il 19 gennaio è stata illustrata a Parigi presso l'Institut Culturel Italien,
davanti ad un pubblico di 250 persone fra critici d'arte, giornalisti e tour operator.
Il 10 febbraio è stata presentata a Londra, presso l'Italian Cultural Institute,
dove si è anche tenuta una degustazione dei prodotti tipici del territorio senese.
Il 17 febbraio è stata promossa a Roma, al Palazzo dell'Informazione, sede di Adnkronos, la nota agenzia giornalistica: qui,
durante la conferenza stampa, il Direttore dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze e il Soprintendente per il Patrimonio Storico
Artistico di Siena e Grosseto, hanno illustrato in anteprima assoluta i restauri eseguiti per l'occasione.
La mostra è stata curata da Max Seidel, storico dell'arte
del Medioevo, del Rinascimento e del XIX secolo, ordinario dell'arte alle università di Zurigo, Göttingen e Heidelberg,
e, fino al 2005, direttore del Kunsthistoriches Institut di Firenze.
Oltre a Max Seidel, la mostra ha impegnato alcuni dei maggiori studiosi dell'arte senese del
Quattrocento, tra i quali Francesco Caglioti (Università di Napoli),
Laura Cavazzini (Università di Messina), Marco Ciatti (Opificio delle Pietre Dure di Firenze),
Andrea De Marchi (Università di Firenze), Maria Monica Donato (Scuola Normale Superiore di Pisa),
Elisabetta Cioni, Gabriele Fattorini e Aldo Galli (Università di Siena).
Info turistiche
LUOGHI
Complesso Museale di Santa Maria della Scala
Complesso dell'Opera del Duomo
Pinacoteca Nazionale
ORARI
Complesso Museale Santa Maria della Scala:
tutti i giorni, compreso festivi
ingresso ore 10.30 - 17.30
(visita fino alle 18.30).
Duomo:
dal lunedì al sabato: 10.30-20.00
domenica e festivi: 13.30-18.30
visite sospese durante le cerimonie religiose.
Museo dell'Opera, Cripta e Battistero:
9.30-20
Pinacoteca Nazionale di Siena:
lunedì 8.30-13.30
da martedì a sabato 8.15-19.15,
domenica e festivi 8.30-13.15.
COSTO INGRESSO
12 €: intero
8 €: ridotto
(over 65, gruppi, convenzioni, possessori di abbonamento o biglietto Trenitalia)
5 €: studenti
0 €: under 6, disabili, accompagnatori e funzionari Ministero Pubblica Istruzione
PARCHEGGIO GRATUITO
Parcheggi Santa Caterina e Stazione Ferroviaria:
3 ore gratuite di parcheggio nel giorno di visita della mostra,
dietro ritiro di apposito coupon alla biglietteria.
RECAPITI MUSEO
tel. 0577 / 224811 - 224835
fax. 0577 / 224829
infoscala@sms.comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
www.rinascimentosiena.it
PROMOTORI
Comune di Siena
Università degli Studi di Siena
Soprintendenza province Siena e Grosseto
Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Opera della Metropolitana di Siena
Fondazione Musei Senesi
Archivio di Stato
Biblioteca Comunale degli Intronati
Complesso Museale Santa Maria della Scala
APT Siena
APT Chianciano Terme - Val di Chiana
Scuola Normale Superiore di Pisa
Kunsthistorisches Institut in Florenz
Istituto Marx-Planck di Firenze
Opificio delle Pietre Dure di Firenze
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
MOSTRA A CURA DI
Max Seidel
Complesso dell'Opera del Duomo
Pinacoteca Nazionale
tutti i giorni, compreso festivi
ingresso ore 10.30 - 17.30
(visita fino alle 18.30).
Duomo:
dal lunedì al sabato: 10.30-20.00
domenica e festivi: 13.30-18.30
visite sospese durante le cerimonie religiose.
Museo dell'Opera, Cripta e Battistero:
9.30-20
Pinacoteca Nazionale di Siena:
lunedì 8.30-13.30
da martedì a sabato 8.15-19.15,
domenica e festivi 8.30-13.15.
8 €: ridotto
(over 65, gruppi, convenzioni, possessori di abbonamento o biglietto Trenitalia)
5 €: studenti
0 €: under 6, disabili, accompagnatori e funzionari Ministero Pubblica Istruzione
3 ore gratuite di parcheggio nel giorno di visita della mostra,
dietro ritiro di apposito coupon alla biglietteria.
fax. 0577 / 224829
infoscala@sms.comune.siena.it
www.santamariadellascala.com
www.rinascimentosiena.it
Università degli Studi di Siena
Soprintendenza province Siena e Grosseto
Fondazione Monte dei Paschi di Siena
Opera della Metropolitana di Siena
Fondazione Musei Senesi
Archivio di Stato
Biblioteca Comunale degli Intronati
Complesso Museale Santa Maria della Scala
APT Siena
APT Chianciano Terme - Val di Chiana
Scuola Normale Superiore di Pisa
Kunsthistorisches Institut in Florenz
Istituto Marx-Planck di Firenze
Opificio delle Pietre Dure di Firenze
Ministero per i Beni e le Attività Culturali